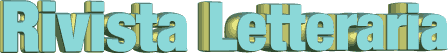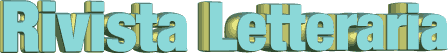Anno XXI n. 1-2/1999
(1) La poesia sarda della solitudine
Due voci contemporanee (2) Gigi Dessì - (3) Salvatore Pintore
di
Oliver Friggieri
dell'Università di Malta
Salvatore Pintore: poesia di
spazi e di silenzi
La stessa semplicità con cui Salvatore Pintore
costruisce la sua lirica in Erano i giorni è già una
metafora tipica della vita isolana. Si tratta di un silenzio interiore,
saturo di significati che si riveleranno man mano che il poeta avanza
nel suo cammino verso se stesso, un abitante ambiguo di una terra
nota e ugualmente sconosciuta, un viaggiatore pieno di ansie e di
interrogazioni. Il sardo diventa subito cittadino del mondo, un interprete
dell’esistenza tramite la conoscenza della propria esperienza
di isolano.
Uno spoglio lessicale della poesia di Pintore mette subito in evidenza
la sua predilezione per un lessico essenziale, fondamentale, da cui
nasce tutta la sua lingua: mistero, silenzio, sguardo, mare, sogno,
passo, segreto, stelle. Prendendo le mosse da una ricca tradizione
lirico?filosofica italiana, che si riconosce in Petrarca, Leopardi,
Pascoli, Ungaretti, Quasimodo, Montale, cioè in una schiera
di fratelli che hanno purificato la lingua letteraria più ricca
d’Europa da tutti i residui della retorica, Pintore riduce il
suo linguaggio al minimo, ricorre a poche parole di facile significato,
adopera forme e strutture sintattiche elementari, scrive con una limpidezza
che mai si perde nelle assurde complessità di tanta poesia
cerebrale del dopoguerra.
La sua espressione sembra aderire alla teoria leopardiana del “peregrino”,
ma si tratta di un rinnovamento del lessico più tipico e comune.
La scelta linguistica emana da una esigenza interiore: Pintore sta
cercando di toccare il limite, di scoprire la profondità del
semplice e dell’immediato. E ciò si fa attraverso una
revisione delle sensazioni più elementari così da scoprire
in queste sensazioni le forme del mistero:
Due occhi sulla riva
sono pronti a salpare
sul messaggio che ha increspato
l’immensa distesa del cuore.
Due occhi dagli abissi
innalzano vele
gonfiano al vento le idee
fendendo le onde del tempo.
Due occhi nell’azzurro
cercano una stella
la sua luce avvolge desiderio
in un silenzioso remare.
Si tratta di un momento caratteristico di tutto l’itinerario.
Pintore adopera la tecnica del bozzettismo, elenca una serie di sensazioni,
descrive le cose alla luce della loro metafisica. In realtà,
il suo quadro è fisico?spirituale, è il risultato di
una riduzione al minimo di tutti gli elementi che lo sguardo, il senso
più insistentemente attivo in tutta la sua opera, penetra e
eventualmente trasforma in esperienza interiore. Il viaggio di Pintore
parte dalle strade affollate dell’isola per poi arrivare alle
parti più remote dell’unica isola vera e propria, la
sua anima, quella che ai giorni d’oggi il poeta può chiamare
in causa anche per essere originale. È un richiamo all’autenticità,
all’infanzia perduta, appunto alla poesia anch’essa tradita
nel nostro secolo da un tipo di produzione che ha perso di vista i
propri punti di riferimento, le sue origini.
La poesia creata in distanza dai grandi centri sembra avere il merito
di aver continuato ad essere fedele a se stessa, di aver continuato
ad insistere sulla verità fondamentale di ogni estetica: la
poesia non esiste nelle cose ma nella sensibilità. Ma anche
il senso della distanza, che noi isolani sentiamo come condizione
inalienabile ma anche forse come vocazione e scelta, ha il suo sapore
metaforico. È una fuga del tutto consapevole, concepita come
scoperta, vissuta come tappa fondamentale di tutto il viaggio. Quello
che nelle grandi città si chiama ecologia, nelle isole è
istinto, natura, comportamento normale. Dunque la fuga è soltanto
l’apparenza di una cosa del tutto diversa: un punto d’arrivo,
una conquista dello spirito:
All’improvviso appare
bussando in uno sguardo
una carezza
una parola...
Furtivo giunge
cercando come un fiume il mare
un letto dove consumarsi
anche sognando.
Nella poetica dello spazio e del silenzio si scopre
il significato di quanto c’è di complesso e di assurdo
nella civiltà del secolo, ugualmente meraviglioso e tragico,
scientifico e barbaro, colto e sconvolto. Quale è il mistero
di cui parla Pintore con tanta insistenza? Perché lui evoca
di poesia in poesia una gamma particolare di sentimenti? Quale è
il motivo per cui ogni momento poetico sembra ricordare il precedente
e anticipare il prossimo? Come sì spiega l’intimo rapporto,
tematico?formale, tra tutte le poesie della raccolta? Alla base di
questa strategia letteraria si può intravedere la mano di un
costruttore delle cose antiche e elementari alla luce di una visione
antica. Si tratta di una ricreazione del mondo, o almeno della propria
coscienza del mondo, secondo una visione che supera i condizionamenti
di luogo e di tempo.
Non basta lo storicismo a spiegare tale comportamento, perché
il tempo stesso è sotto accusa. Forse è la terra, l’isola
nella sua essenziale immutabilità a suggerire e a imporre questo
modo di sentire le cose. Pintore consapevolmente perde il senso del
flusso continuo e riscopre la vita come mistero, l’antitesi
della scienza, l’opposto della razionalità. Ciò
che a prima vista è sembrato un paradosso altro non è
che la superficie del metafisico, inteso, se si vuole, anche in termini
laici, anche se sotto tale profilo ogni laicismo è necessariamente
religioso:
L’invisibile non vedono
i nostri occhi votati
alla luce del mistero.
Avvicinando il mondo
si dispiega il gioco e la danza
di terra e cielo.
L’esperienza risplende nell’anima.
Ad essa inclina lo sguardo
chi pensa il più profondo.
Il modello immaginativo conduttore è quello
del viaggio. È impossibile per un poeta mediterraneo dimenticare
che il padre, Ulisse, fosse un navigatore, un instancabile viaggiatore
in cerca di se stesso. Dall’Odissea all’Eneide, dalla
Divina Commedia all’Ulisse di Joyce, tutti i poeti si sono riconosciuti
nella figura dell’uomo come turista del cosmo, in ultima analisi
dell’uomo in cerca del senso del suo essere. Il mare e la terra
si traducono in materia di costruzione per la rappresentazione scenica
di una esperienza interiore. Pintore si inserisce subito in questa
tradizione e si adatta senza difficoltà alle condizioni moderne
del viaggio, cioè ad un viaggio che nel mare e nella terra
vede soltanto spunti metaforici. La poesia paesaggistica del Novecento
non ha niente a che fare con l’ecologia, anche se è apparentemente
ecologica; così è stata sempre la poesia fin da Orazio
e tanti altri. La situazione del secolo è ben più complessa
- è il secolo messo a confronto con se stesso. La proposta
poetica è il ritorno all’essenziale, al riconoscimento
del mistero nascosto dentro le cose.
Il Mediterraneo come terra e mare e spazi e silenzio, dunque, continua
ad essere lo scenario del viaggiatore. Fernand Braudel ha detto: “Cos’è
il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli
paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà,
ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare
nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la
preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, la presenza
araba in Spagna, l’Islam turco in Jugoslavia. Significa sprofondare
nell’abisso dei secoli, fino alle costruzioni megalitiche di
Malta o alle piramidi d’Egitto”.
Rimanere fedeli al Mediterraneo, dunque, significa rimanere fedeli
alla necessità di scoprire e di conoscere, di andare oltre
il limite del tempo e dello spazio. Poesia concepita e creata secondo
questa necessità è poesia di fedeltà all’essenziale.
Anche per tale motivo la lirica di Salvatore Pintore è autenticamente
e modernamente mediterranea. Si costruisce sulla identificazione dell’uomo
come viaggiatore. Da un lato c’è lo spazio, fisico in
sé ma metaforico in sostanza: cielo, nubi, abissi, onde, azzurro,
stella, immenso, sentieri, mare, stelle, terra, fiume, vento, via,
orizzonte, confine, riva. Dall’altro lato c’è il
movimento continuo: salpare, vele, remare, correre, visite, giunge,
cercando, ritornano, arriva, guidi, muove, danzando, aprirsi, scorrono.
C’è anche il viaggiatore, descritto in termini ben precisi.
sguardo, solitario, passo, silenzi, cuore. Sarebbe opportuno fare
un completo spoglio lessicale di Erano i giorni per mettere in evidenza
questo suo carattere unitario secondo tre punti di riferimento: l’ambiente
del viaggio, l’esperienza del viaggio, il viaggiatore.
Due brani particolare sintetizzano sia il tema sia i mezzi di costruzione
poetica. In essi Pintore mette in un armonioso insieme tutti gli elementi
costitutivi della sua visione fisico?spirituale. E' superato lo spazio
tra il mondo esterno e il mondo interiore, è eliminata la distinzione
tra viaggio reale e viaggio metaforico. L’isola si è
trasformata in un simbolo della coscienza. Non c’è più
l’uomo che vive nell’isola, ma solo l’isola che
abita dentro di lui. Il viaggiatore mediterraneo non si definisce
più in termini culturali e geografici:
Palpitanti desideri scorrono
inseguono corolle d’amore
verso il cuore del mondo.
(Aiuto!)
Ma aprirsi
al destino che incombe
come un miracolo
per dialogare con la luce
che abita il tuo cuore
socchiuso all’incontro con l’Altro.
(Un bianco desiderio)
Dalla
consapevolezza del dualismo tra l’io e l’altro nasce il
desiderio di andare oltre i confini già conosciuti, appunto
verso l’ignoto, il mistero di cui Pintore parla insistentemente
con un miscuglio di fede e di paura. Alla luce di queste considerazioni,
di natura tematico-formale, sul viaggio di Pintore può iniziare
un altro discorso, di natura psicologica, su quello che Neria De Giovanni
sinteticamente chiama “viaggio nel labirinto della vita, alla
scoperta di un vero rapporto-relazione con gli altri”.